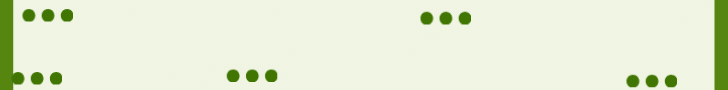Fotoreporter per caso
Intervista all'inviato di guerra Roberto Roggero

Nato a Genova nel 1965, il fotoreporter Roberto Roggero, ha studiato lingue all’università e si è avvicinato alla comunicazione grazie al padre, appassionato di fotografia. Dopo varie esperienze, tra una parentesi vissuta in Andalusia e un periodo di lavoro su navi da crociera, ha iniziato la carriera di inviato di guerra nel 1992, partendo per Sarajevo e poi nei Balcani. Ha condotto inchieste su temi delicati come criminalità organizzata e servizi segreti, e ha lavorato in zone di conflitto come Messico, Afghanistan, Iraq, Kuwait, Libano, Siria, Yemen, Libia, Iran, Giordania, Oman e Qatar. Ha vinto premi giornalistici e alcuni suoi scritti sono nella Biblioteca del Quirinale. È membro della Investigative Reporters & Editors Association, vicedirettore della rivista online StoriaVerità, e direttore responsabile di Assadakah News, agenzia stampa e informazione che lavora con i Paesi arabi.

Partiamo dalle origini: cosa ricordi della tua infanzia a Genova e come ha influenzato il tuo percorso di vita?
“Ho avuto infanzia e giovinezza abbastanza agevoli, i miei genitori mi hanno sempre incoraggiato per quanto riguarda iniziative culturali, sono stati come si usa dire, severi ma giusti. Sono cresciuto nel ristorante dei miei nonni quindi costantemente a contatto con gente di diverso tipo e al tempo stesso casa mia era frequentata da scrittori e musicisti. Papà ha coltivato per tutta la vita la passione per musica, canto, fotografia, storia, e mamma quella per libri, arte e cultura in genere”.

La passione per la fotografia ti è stata quindi trasmessa da tuo padre. Qual è stato il primo scatto che ha avuto un significato speciale per te?
“Caspita, qui andiamo nell’antichità…Sinceramente non ricordo il primo scatto speciale…avevo circa quattro-cinque anni…ricordo piuttosto quel periodo in genere perché ogni tanto rispolvero le vecchie diapositive”.
Come ha influito il Liceo Classico sulla tua visione del mondo e sulla scelta di intraprendere la carriera nella comunicazione?
“L’indirizzo classico ha avuto una influenza fondamentale. Non è un segreto che sia una piattaforma base che offre il giusto approccio anche a studi scientifici, almeno in linea di massima. Mia nonna mi avrebbe voluto medico o veterinario, ma quando gli insegnanti del liceo le hanno detto che la mia arma era la penna, ha cambiato idea. Certo, non sono stato uno studente particolarmente brillante, ho ripetuto due anni, poi ne ho fatto due in uno e l’esame di maturità da privatista, con tutti gli scritti e tutti gli orali. E’ stata un’estate atroce…Anche all’università non sono stato un campione, perché sono stati anni in cui ho cominciato a fare anche molte altre cose…con una parentesi di scenografia in teatro, con alcuni amici usciti dalla scuola di Gino&Michele…mi sono divertito davvero tanto in quell’occasione…”.
 All’università hai studiato lingue, come mai hai scelto spagnolo e inglese? Hai mai pensato di esplorare altre lingue?
All’università hai studiato lingue, come mai hai scelto spagnolo e inglese? Hai mai pensato di esplorare altre lingue?
“Ho scelto inglese perché già avevo imparato a conversare ed esprimermi grazie ai testi delle canzoni…Ricordo che come esercizio mi appassionava imparare le canzoni, e sapere che cosa dicessero, quindi me le traducevo. Ricordo che a forza di ascoltarle, ho imparato a memoria le magnifiche opere rock ‘Jesus Christ Superstar’, ‘Hair’ e ‘The Rocky Horror Show’. Con lo spagnolo lo stesso, oltre ad avere approfittato del periodo vissuto in Andalusia. Quando mi sono accorto di avere una certa propensione per la materia in questione, ho pensato di mettere a frutto la cosa con gli studi universitari. Altre lingue certo, se trovassi la leggendaria lampada, uno dei tre desideri sarebbe certo quello di parlare tutte le lingue del mondo. Più di tutte mi affascina e mi rapisce la musicalità della lingua araba, ma anche gli ideogrammi delle lingue orientali, le stupende inflessioni e le immagini grafiche delle lingue africane…”.
Qual è stato il momento esatto in cui hai capito che la comunicazione sarebbe diventata la tua carriera?
“Quando mi sono appassionato allo studio della storiografia critica revisionista, credo in seconda o terza media. Mi trovavo completamente a mio agio nello svolgere i temi di italiano, e in storia mi incuriosiva andare a cercare le cause degli avvenimenti che i libri non citavano. Insomma, non mi accontentavo della versione che leggevo sui testi e facevo ricerche per mio conto. Non riuscivo a stare zitto durante le lezioni, quando non trovavo senso logico soddisfacente anche nelle esposizioni degli insegnanti”.
 Dopo l’università hai iniziato in una redazione di logistica e nautica. Cosa ricordi di quell’esperienza e cosa ti ha insegnato?
Dopo l’università hai iniziato in una redazione di logistica e nautica. Cosa ricordi di quell’esperienza e cosa ti ha insegnato?
“Mi sono accorto che, molto spesso, anzi quasi sempre, il mondo del lavoro è una giungla dove vige la legge ‘mors tua, vita mea’. Era il mio primo impiego, e dopo anni di contratto a collaborazione e centinaia di articoli, quando doveva scattare la tanto attesa assunzione, mi hanno dato il benservito e mi sono ritrovato in mezzo alla strada, con un figlio nato da poco. Non sono stato a guardare, ho combattuto e l’ho spuntata: l’Ordine Nazionale Giornalisti mi ha riconosciuto il periodo come avvenuto praticantato e ho subito affrontato l’esame da professionista. In ogni caso, certo ho avuto la mia prima esperienza di quella che si dice ‘cucina giornalistica’, ho cominciato a imparare il mestiere e a prendere coscienza soprattutto di ciò che non va fatto”.
Hai lavorato sulle navi da crociera. Quali lezioni di vita hai appreso durante i tuoi viaggi in mare?
“Una esperienza che mi è servita. Mi sono imbarcato come Allievo Commissario, approfittando del fatto che metà della famiglia, da parte di madre, era sparpagliata per tutti gli oceani, ma dopo non molto mi sono accorto che non era una vita per me…Si sa che, sulle navi, o ti viene la cosiddetta ‘malattia del ferro’ e non scendi più a terra, oppure fuggi a gambe levate, nonostante gli ottimi guadagni e la possibilità di vedere bellissimi luoghi…ma l’ho trovato un ambiente troppo artificiale, finto, fatto prevalentemente di apparenza e dove si usa nascondere la cenere sotto il tappeto…Non faceva per me”.
Quando hai vissuto in Andalusia, cosa ti ha colpito di più della cultura e delle persone del posto?
“Un periodo stupendo…per circa due anni ho vissuto praticamente scalzo, in una casetta sulla spiaggia di Los Canos de Meca, sull’Atlantico, e mi spostavo con un cavallo nero che si chiamava Felipe. Del posto mi ha affascinato tutto. C’ero capitato la prima volta per caso, tappa dopo tappa lungo la costa spagnola, poi ci sono tornato l’anno seguente, e poi ancora, finché gli anziani del posto mi hanno chiesto se volevo restare, e sono rimasto. La cosa bella è in particolare il fatto che anche laggiù la gente si sveglia al mattino, va a lavorare, torna a casa, mangia, dorme e tutto il resto, ma in una dimensione con tempi umani. Non ho mai sentito nessuno pronunciare la parola ‘stress’. Sono rimasto affascinato dalla fusione culturale e dall’influenza araba, dalla musica, dalla spontaneità della gente che quando passeggi per strada ti invita a bere un caffè, dal sole e dal mare, e da un sacco di altre cose…”.
 Nel 1992 è iniziata la tua carriera di inviato di guerra. Cosa hai provato nel momento in cui ti è stato chiesto di sostituire un inviato per Sarajevo? Come è stato immergersi in una realtà così difficile? Qual è stato il momento più significativo di quel periodo?
Nel 1992 è iniziata la tua carriera di inviato di guerra. Cosa hai provato nel momento in cui ti è stato chiesto di sostituire un inviato per Sarajevo? Come è stato immergersi in una realtà così difficile? Qual è stato il momento più significativo di quel periodo?
“…Beh, direi che forse inizialmente non mi sono reso ben conto della scelta che avevo fatto. Mi erano stati concessi venti secondi per dire si o no, perché il direttore di quella rivista doveva inviare i miei dati allo stato maggiore dell’esercito per la registrazione, e c’erano pochi giorni per preparare tutto.
L’impatto è stato a dir poco devastante. Da un giorno all’altro mi sono trovato dalla tranquillità di casa all’inferno dei Balcani e a Sarajevo, fra urla, spari, esplosioni di bombe d’aereo e mine, e ho visto che cosa fosse la paura sui volti della gente, gli estremi opposti nella considerazione del valore della vita, la sofferenza di anziani, donne e bambini, la rabbia di chi sceglieva di imbracciare le armi, le stragi di massa, villaggi rasi al suolo e cadaveri fumanti, le due facce della diplomazia e della realtà sul campo. Diverse volte si sentiva dire che in una certa zona era stato raggiunto l’accordo per il cessate-il-fuoco, e nella stessa zona avevano inizio la caccia alle streghe, vendette personali, guerra fra bande per il monopolio del contrabbando di ogni genere di merce, per il potere e la supremazia etnica e quindi politica, in un vero e proprio mosaico estremamente eterogeneo. Ho visto i soldati italiani impegnati a bonificare una delle zone più minate del mondo, con ordigni di fabbricazione prevalentemente italiana, e molte altre cose paradossali. In Kosovo, la NATO ha combattuto una guerra per smilitarizzare l’UCK, considerato una sorta di formazione estremista, e una volta raggiunto lo scopo, e il Kosovo ha raggiunto lo status indipendente, quando occorreva una forza di polizia che garantisse l’ordine pubblico, gli unici in grado di affrontare tale compito erano gli stessi guerriglieri, richiamati, vestiti in uniforme e nuovamente armati.
 Non che esistano guerre ‘pulite’, ma quella dei Balcani è comunque stata una guerra davvero ‘sporca’…come quella che si sta combattendo in Ucraina, e nella quale l’informazione è continuamente orientata verso una sola versione…”.
Non che esistano guerre ‘pulite’, ma quella dei Balcani è comunque stata una guerra davvero ‘sporca’…come quella che si sta combattendo in Ucraina, e nella quale l’informazione è continuamente orientata verso una sola versione…”.
Come gestisci tensione, rischio e paura?
“E’ una domanda che ha almeno cento risposte diverse…Sono tutti elementi che fanno parte del lavoro. Diversi stadi emozionali. La tensione inizia da quando salgo sull’aereo per partire a quando scendo, al rientro. C’è tensione e tensione, da quella diciamo ‘normale’ di trovarsi già in un contesto particolare, alla tensione di quando ci si trova in mezzo al frastuono delle esplosioni. La tensione permette di restare vigili, di gestire la paura (guai se non si provasse paura), e di valutare il rischio, ovvero fin dove si può arrivare e che cosa si è disposti a fare. Qui subentrano diversi elementi caratteriali, quindi dipende dal singolo individuo, e in questo senso credo di essermi spinto ai limiti, sia durante la guerra in Iraq e Kuwait, sia in Siria”.
 Come selezioni le storie da raccontare? Quali elementi ti portano a scegliere una storia rispetto a un’altra?
Come selezioni le storie da raccontare? Quali elementi ti portano a scegliere una storia rispetto a un’altra?
“Bella domanda…le storie di guerra comprendono un po’ tutto, almeno cerco di illustrare i più differenti aspetti che formano un contesto di crisi come una guerra. C’è l’accanimento e lo stress dei soldati, la volontà di vendetta dei guerriglieri, la disperazione della gente che non sta né da una parte né dall’altra, il grande lavoro degli operatori umanitari, e poi morti e feriti, bambini traumatizzati, il determinare quanto costa una guerra in termini economici, e soprattutto, ricollegandomi al filosofo cinese Sun-Tzu, la domanda regina: cui prodest?”.
Le missioni all’estero ti hanno portato in territori di conflitto come Afghanistan, Iraq, Libano e Siria. Quale di questi Paesi ti ha colpito maggiormente e perché? Hai notato differenze nell’impatto della guerra su queste popolazioni rispetto ad altre aree di conflitto?
“Impossibile una risposta definita. Ogni Paese mi ha catturato, per un verso o per un altro. Messico, Afghanistan, Iraq, Kuwait, Libano, Siria, Iran, Giordania, Yemen, Oman, tutti luoghi in cui sono nate civiltà che hanno dato origine alla società come oggi la conosciamo…anche se in certi casi non è stato un buon lavoro. Comunque non so rispondere con un nome, ogni luogo ha il suo fascino. Quale Paese mi ha colpito di più? Potrei risponderti…il prossimo…”.
 Qual è stato il ruolo delle comunità locali nel tuo lavoro? Hai collaborato con persone del posto per documentare storie di guerra?
Qual è stato il ruolo delle comunità locali nel tuo lavoro? Hai collaborato con persone del posto per documentare storie di guerra?
“Sono sempre in mezzo alla gente del posto. Anche se li incontro per interviste varie, la verità di certe situazioni non sta negli uffici dei generali, o delle personalità di governo, la trovi solo sulla strada, fra le macerie, negli ospedali, nei campi profughi. E’ stampata sulle facce della gente che subisce impotente”.
Quali sono stati i momenti più critici che hai vissuto?
“Momenti critici in trent’anni ce ne sono stati tanti, ma l’apice è stato in Siria, durante una perlustrazione insieme ai combattenti di Hezbollah con uno sconfinamento dal Libano. Insomma, per cavarmi fuori da una situazione di emergenza, l’istinto di sopravvivenza ha avuto il sopravvento. E’ stata questione di pochi secondi, ma se non avessi agito in quel determinato modo, ora non sarei qui a raccontarlo”.
Ti è mai capitato di doverti confrontare con milizie o gruppi armati locali per ottenere un’intervista o accedere a una zona di conflitto? Come hai gestito questi incontri?
“E’ capitato. Quando c’è stato il terremoto che ha colpito Turchia e Siria, nel febbraio 2023, la associazione di cui faccio parte, dove mi diverto a suonare il basso, e che gestisce numerose iniziative, ha messo insieme una piccola donazione, e l’ho portata a una famiglia fra quelle colpite dal sisma, passando per una zona della Siria controllata da una formazione fondamentalista. Da quelle parti ci si basa molto sulla conoscenza personale e sulla fiducia, e grazie al fatto che il mio contatto locale era stato a scuola, da bambino, con uno dei capi di questa formazione, ho potuto attraversare la zona senza eccessivo rischio, fino al confine con la Turchia, e soprattutto tornare indietro…A Beirut, sempre grazie al contatto locale, ovvero l’amico Talal, sono arrivato al responsabile delle relazioni estere di Hezbollah, e poi al comandante militare della stessa organizzazione. In questo lavoro, i contatti sono fondamentali”.
 Le tue indagini sui cartelli del narcotraffico e i movimenti indipendentisti, dall’ETA ai nazionalisti corsi: qual è il filo conduttore che unisce queste esperienze?
Le tue indagini sui cartelli del narcotraffico e i movimenti indipendentisti, dall’ETA ai nazionalisti corsi: qual è il filo conduttore che unisce queste esperienze?
“Volevo evidenziare situazioni di cui qui da noi si parla poco o niente. Oltre alle guerre conclamate di largo respiro e guerre per procura come Russia-Ucraina, Israele-Hamas-Hezbollah o Cina-Taiwan. Già si parla poco di conflitti come quello del Sudan o dello Yemen, o di Paesi come Myanmar dov’è in atto un altro genocidio contro la popolazione Rohyngya, nella totale indifferenza internazionale, figuriamoci di situazioni di crisi come le famiglie coinvolte nelle faide messicane, magari costrette alla fuga verso il confine americano, o quelle che sono state confinate nelle province remote della Spagna meridionale in seguito alla fine della lotta armata dell’ETA basca, o i regolamenti di conti della criminalità organizzata e delle formazioni indipendentiste in Corsica. La criminalità locale in Corsica gestisce diverse attività, per altro notevolmente remunerative, poi ci sono i combattenti per l’autonomia, con figure storiche che ricordano gli eroi romantici dei romanzi, raffigurati con il caratteristico ‘vendetta’, il tipico coltello, stretto in pugno o infilato nella cintura di cuoio…”.
 Fra le numerose inchieste svolte in Italia, qual è quella che ti ha procurato più difficoltà e quale è stata più gratificante?
Fra le numerose inchieste svolte in Italia, qual è quella che ti ha procurato più difficoltà e quale è stata più gratificante?
“Ne ho svolte diverse, e in effetti tutte mi hanno coinvolto. C’è stata la massoneria, poi uno scandalo edilizio in Liguria, per il quale ho subito un processo per diffamazione durato circa otto anni, denunciato da un importante istituto di credito e holding collegata, che avevo accusato di violazione del segreto bancario. E’ finito bene, dal momento che le mie fonti erano delle intercettazioni ambientali della Procura e altri documenti di provata provenienza. Per una questione simile, collegata a un’inchiesta su certi appalti in Sicilia e Calabria, che poi ha anche avuto diramazioni in Puglia, rese note dalla trasmissione ‘Report’, e con tanto di testimoni diretti, sono stato invece condannato in primo grado, pur con la collaborazione di una agenzia investigativa e con tanto di verbali timbrati dalla Procura…Ho intervistato l’avvocato della compagnia aerea Itavia che mi ha fatto interessanti rivelazioni sui fatti di Ustica, poi un’altra su alcuni collegamenti fra navi dei veleni e traffici marittimi fra Genova, Gioia Tauro e la Somalia, con in mezzo la drammatica morte di Ilaria Alpi…e anche in questo caso sono venuto a conoscenza di particolari non ufficialmente noti…La difficoltà, in sostanza, è il venire a sapere quei particolari e collegamenti che si cercano, e poi non avere la possibilità di renderli noti. Si sa, quando la legge è uguale per tutti…”.
Hai svolto ricerche e inchieste sui servizi segreti di vari Paesi. Cosa ti ha spinto ad approfondire questo tema e quale sfida è stata più complessa?
“Beh, si sa che il mondo delle spie è affascinante, conturbante, misterioso…Anni fa scrivevo per una rivista davvero molto bella, professionale, fatta davvero bene, si chiamava ‘Dossier Intelligence’ ed era pubblicata dal Centro Internazionale di Studi ‘John Nicholas Harris’ di Bologna. Ho pubblicato diverse inchieste iniziando dagli apparati dell’intelligence di Paesi arabi, credo si sia trattato del Mukhabarat iracheno ai tempi di Saddam Hussein, poi Siria, Iran, Egitto, Turchia, poi sono passato a Germania Est, Cuba, Giappone, Cina, e non ricordo quali altri…La sfida più complessa è sempre quella più interessante, e credo sia stato il dossier sulla Stasi, la polizia politica segreta della DDR”.

Qual è stato il contributo di ICSM e di StoriaVerità alla tua formazione e carriera? Hai ricevuto numerosi premi e riconoscimenti; quale di questi ha significato di più per te, e perché?
“L’Istituto di Cultura e Storia Militare è una celebre istituzione, collegata a diverse testate con le quali ho collaborato, come la nota ‘Rivista Marittima’, e sono piattaforme che hanno avuto un valore nella mia formazione. Ho avuto occasione di approfondire soprattutto le nozioni tecniche in materia di dotazioni, armamenti, strategia.
StoriaVerità è un discorso a parte, una rivista nata cartacea e oggi online, ‘politicamente scorretta’ in quanto percorre la strada dei coni d’ombra, dell’indagine storiografica revisionista, della verità non sempre rivelata, specie in materia di geopolitica, termine spesso frainteso o male interpretato. Su questa testata scrivono autori e ricercatori di richiamo internazionale, e il direttore, Alberto Rosselli, è un caro amico con il quale collaboro da tanti anni e che ha avuto a sua volta decennali esperienze di corrispondenza di guerra. Farne parte come vicedirettore è un piacere e un privilegio.
Per quanto riguarda i riconoscimenti, certo fa piacere che il proprio lavoro venga apprezzato, ma vorrei fossero impulsi per il riconoscimento di una categoria ancora troppo bistrattata, poco considerata, quella del giornalista libero professionista, o freelance”.
Il tuo lavoro è presente in oltre 16mila università. Che tipo di messaggio speri di trasmettere alle future generazioni di studenti e studiosi, o a un giovane che vorrebbe seguire un percorso simile al tuo?
“Anzitutto che tanti titoli e citazioni devono essere sostenuti dalla sostanza e da un continuo aggiornamento. Il fatto che un libro o un altro sia presente nelle biblioteche o sia utilizzato in documenti citati da atenei universitari di diversi Paesi è un riconoscimento che vale molto più di mille attestati o premi, perché significa che la divulgazione funziona, che le nuove generazioni sono interessate alla rivalutazione della storia, in funzione di un futuro con meno errori…insomma che si smetta di non volere imparare dalla lezione della storia. E per un giovane che fa la mia scelta, che devo dire…non aspettarti di diventarci ricco, se è così non cominciare nemmeno! A parte questo, è una scelta non facile, nella quale devono entrare molti elementi, fra cui il mettere a rischio sé stessi”.
 Qual è stato l’incontro professionale più importante nella tua carriera, e che impatto ha avuto sulla tua visione del giornalismo?
Qual è stato l’incontro professionale più importante nella tua carriera, e che impatto ha avuto sulla tua visione del giornalismo?
“Non è stato uno solo. Ricordo diversi incontri che non sono mai stati solo professionali, ma senza dubbio son andati ben oltre. Da personaggi come il grande Gino Strada, a persone della strada, famiglie di gente comune, colleghi che purtroppo hanno pagato con la vita la passione per la verità e le overdosi di adrenalina naturale, poi alcuni che sono diventati più che amici, come Alberto Rosselli che ho citato prima, o Talal Khrais, a sua volta corrispondente di guerra e fondatore della associazione Assadakah, conosciuto a Beirut, e con il quale ho cominciato a lavorare e lavoro tutt’ora, insieme a un altro giornalista esperto come Muhammad Youssef Ismail Alì, e la stessa associazione Assadakah, che festeggia i trent’anni di attività. Sono fra le persone più professionalmente preparate che abbia mai incontrato”.
Papà di tre figli, un’attuale compagna, il basso in un gruppo reggae, libri di storia e geopolitica, un romanzo, un libro sulle esperienze di guerra…Come riesci a conciliare la tua vita personale, familiare e artistica con una carriera così impegnativa?
“…Beh, mi trovo a mio agio in maschera a Carnevale e Halloween, come nelle aule scolastiche a insegnare tecniche giornalistiche, in una trincea di prima linea, a guardare un film o nelle cene di ambasciata. Cerco di non annoiarmi…”.

Intervista a Roberto Roggero su Arcoiris
https://www.arcoiris.tv/scheda/it/3887/
![]()